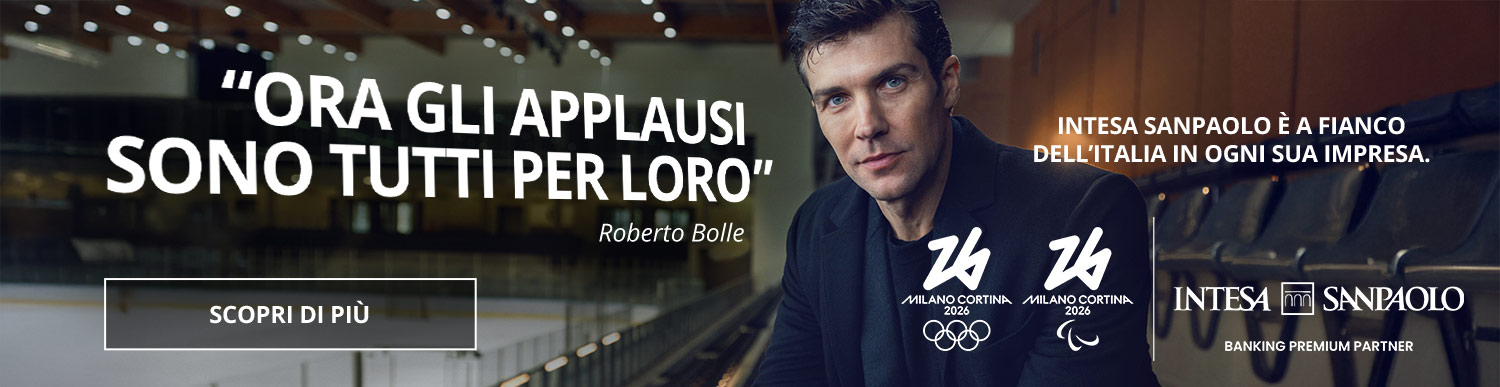Il meccanismo di aiuti per 91 settori energivori, in vigore dal 2026, si scontra con la realtà: gli sconti copriranno solo metà dei consumi e saranno vincolati a investimenti immediati. Gli imprenditori avvertono: “Così la misura è inefficace”, mentre cresce la pressione per una revisione delle norme UE.
Un ambizioso piano per calmierare i costi elettrici delle imprese ad alta intensità energetica, destinato a entrare in vigore dal 2026, sta generando reazioni tutt’altro che entusiaste tra gli imprenditori, che pure in un primo momento avevano salutato con soddisfazione la misura. Il progetto messo a punto dal ministero federale dell’Economia prevede sconti mirati per 91 comparti industriali. Tuttavia, secondo quanto rivela l’Handelsblatt, la combinazione di agevolazioni parziali, vincoli sugli investimenti e limiti temporali sta sollevando dubbi sulla reale efficacia del meccanismo nel sostenere la competitività delle aziende.
CRITERI DI ACCESSO E PRIME CRITICHE
Secondo la bozza ministeriale, solo metà del fabbisogno elettrico acquistato dalle imprese potrà beneficiare della riduzione, un’impostazione che molti operatori giudicano insufficiente per avvicinare il costo dell’energia ai 5 centesimi per chilowattora promessi in precedenza dalla coalizione di governo. A ciò si aggiunge l’obbligo di destinare almeno il 50% del beneficio ricevuto a iniziative di ammodernamento e miglioramento tecnologico, come il rinnovamento degli impianti produttivi. Associazioni di settore, tra cui quella dell’industria del calcare, contestano che tali condizioni riducano significativamente la portata dello strumento, perché legano il sostegno alla realizzazione di investimenti impegnativi e non sempre immediatamente attuabili.
Il ministero ha definito la misura seguendo i criteri del quadro comunitario per gli aiuti di Stato nell’ambito della transizione industriale (CISAF), che introduce anche un limite di durata di tre anni (ecco perché la misura è stata programmata dal 2026 al 2028). Da più fronti arrivano richiami alla necessità di regole europee più flessibili, ritenute essenziali per evitare che la cornice normativa ostacoli le iniziative per rafforzare la competitività dell’industria continentale.
CONTROPARTITE, BONUS E ONERI AMMINISTRATIVI
La bozza elenca un ventaglio di interventi che possono essere classificati come “contropartite”, tra cui lo sviluppo di capacità per la produzione interna di energia rinnovabile, sistemi di accumulo, soluzioni di gestione flessibile della domanda, investimenti nell’efficienza energetica e progetti legati all’impiego di idrogeno a basse emissioni. Ulteriori misure, come nuovi collegamenti alla rete o la stipula di contratti diretti con produttori di energia rinnovabile, sono oggetto di confronto con Bruxelles. Tutte le attività finanziate, salvo proroghe per ragioni tecniche, dovranno essere completate entro 48 mesi.
Le imprese ad alta intensità energetica potranno inoltre accedere a un “bonus di flessibilità”: se almeno l’80% delle risorse investite è destinato a incrementare la capacità di modulare i consumi elettrici, il contributo sarà accresciuto del 10%. Il ministero considera la flessibilità industriale una leva fondamentale per un migliore utilizzo delle fonti rinnovabili, caratterizzate da una disponibilità variabile.
Molte aziende sottolineano però che gli obblighi di verifica, la documentazione richiesta e la necessità di ricorrere a consulenze specialistiche comportano un aggravio amministrativo significativo. In diversi casi, osservano i rappresentanti del settore, una parte consistente dell’agevolazione viene assorbita dai costi procedurali. Alcune stime indicano che, considerando gli attuali prezzi all’ingrosso dell’energia, lo sconto effettivo sul costo totale si ridurrebbe a una cifra percentuale modesta.
SETTORI INTERESSATI E PROSSIME TAPPE
L’elenco dei comparti potenzialmente beneficiari riprende la classificazione europea “Kuebll” (acronimo tedesco: Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien), che identifica le industrie particolarmente energivore e sottoposte a forte concorrenza internazionale. Le 91 categorie comprendono attività chimiche, metallurgiche, ceramiche di lavorazione di gomma e plastica, produzione di vetro, cemento e componenti per batterie e semiconduttori, oltre a parti dell’industria cartaria ed estrattiva.
La coalizione formata da Cdu, Csu e Spd ha stabilito che le imprese potranno presentare domanda dal 2027 con applicazione retroattiva all’anno precedente. L’Handelsblatt spiega che il costo complessivo del programma, secondo la stima attuale, si aggira sui 3,1 miliardi di euro nell’arco dei tre anni di validità. Il nuovo regime non sarà cumulabile con l’attuale meccanismo di compensazione dei costi legati alla CO2, che il ministero sta nel frattempo negoziando di prorogare oltre il 2030 ed estendere a ulteriori settori. Le imprese potranno comunque scegliere annualmente quale dei due strumenti utilizzare.
Nelle prossime settimane, in parallelo al confronto finale con la Commissione europea, il governo federale prevede di definire il documento definitivo e impostare le linee guida operative per l’attuazione del futuro prezzo dell’elettricità industriale.