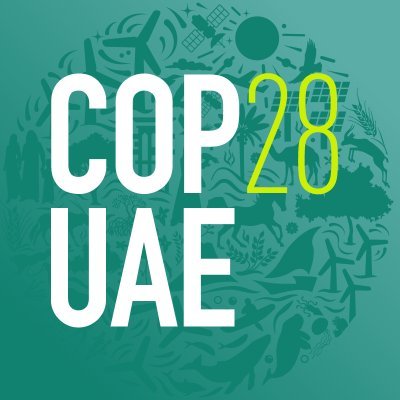Per il think tank Bruegel la COP28 probabilmente si concluderà con un risultato contrastante, che sarà celebrato da alcuni e denigrato da altri. Gli indicatori di successo dipenderanno in gran parte da impegni più ambiziosi e da azioni concrete per promuovere l’attuazione degli obiettivi
La ventottesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) – che inizierà a Dubai il prossimo 30 novembre – sarà per la prima volta ospitata da un Paese membro dell’OPEC, gli Emirati Arabi Uniti. La conferenza sarà presieduta da Sultan Al Jaber, amministratore delegato della compagnia petrolifera ADNOC, il che suscita timori di greenwashing e conflitti di interessi.
Il primo bilancio dell’azione globale per il clima nell’ambito dell’Accordo di Parigi sarà presentato a Dubai, offrendo un’opportunità per affrontare il fallimento del mondo nell’affrontare la crisi climatica e per spingere le azioni verso la direzione corretta. La COP28 si svolgerà nel mezzo della guerra in Ucraina e del conflitto tra Israele e Hamas, il cui impatto sulle alleanze internazionali probabilmente avrà conseguenze sui negoziati sul clima. Il think tank Bruegel ha analizzato le questioni chiave in gioco e ha proposto alcuni indicatori per misurare il successo dell’imminente vertice ONU sul clima.
LA COP28: UN BILANCIO GLOBALE
L’accordo di Parigi impone una valutazione periodica dell’azione globale per il clima, chiamata Global Stocktake (GST). Il processo, durato 5 anni, ha coinvolto scienziati, attori istituzionali e il settore privato attraverso la We Mean Business Coalition. Il suo scopo principale è facilitare la valutazione dei progressi in corso e spingere per impegni più forti.
Il GST che sarà adottato a Dubai si concentrerà su tre ambiti chiave: mitigazione, adattamento e finanza climatica. Poiché a Glasgow i contributi aggiornati stabiliti a livello nazionale (Nationally Determined Contributions – NDC) non sono riusciti a mettere la comunità globale sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di temperatura, i risultati del GST sono pronti per un esame approfondito.
Gli NDC sono obiettivi e azioni stabiliti dai singoli Paesi per ridurre le emissioni di gas serra: consentono di valutare e confrontare gli sforzi di ciascun Paese per ridurre le emissioni di carbonio, valutando se le azioni globali e nazionali sono allineate con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Una volta completato il GST, i Paesi avranno due anni per rivedere i propri NDC.
Tuttavia, il modo in cui il GST sarà definito alla COP28 sarà importante per creare slancio per affrontare il cambiamento climatico. La COP28 deve trasmettere ai governi, alle aziende e ai mercati finanziari l’importanza di una migliore integrazione delle considerazioni climatiche nel processo decisionale economico e finanziario pubblico e privato.
L’ABBANDONO DEI COMBUSTIBILI FOSSILI
La COP27 si è conclusa con disposizioni generiche sulla necessità di promuovere “l’energia a basse emissioni” e ha fatto poco per definire il futuro dei combustibili fossili. Tuttavia, all’inizio di quest’anno i leader del G7 hanno dichiarato il loro obiettivo di fare affidamento prevalentemente sulle energie rinnovabili entro il 2035 e si sono impegnati ad intensificare gli sforzi per eliminare gradualmente la produzione di energia da carbone (in cui le centrali elettriche generano carbone senza attrezzature per il controllo delle emissioni come le tecnologie di cattura o stoccaggio del carbonio).
Alla COP28 ci saranno pressioni per definire le scadenze per l’eliminazione progressiva dei combustibili fossili. L’Ue sta apportando capitale politico a sostegno di questo obiettivo, con i Paesi membri che sostengono l’eliminazione globale di tutti i combustibili fossili senza sosta prima del 2050. I Paesi Ue hanno anche chiesto una riduzione immediata dei sussidi ai combustibili fossili. Questo probabilmente sarà un punto di contesa per i Paesi in via di sviluppo alla COP28: questi ultimi preferirebbero che i Paesi sviluppati raggiungessero il net zero ben prima del 2050, in modo che un bilancio di carbonio più ampio potrebbe essere assegnato ai Paesi che ne hanno più bisogno.
LA QUESTIONE DELLE EMISSIONI SCOPE 1-2-3
La presidenza della COP28 non si sottrae a questa discussione, ritenendo l’eliminazione graduale dei combustibili fossili “essenziale e inevitabile”. Tuttavia, i negoziati ruotano attorno alle emissioni Scope 1 e 2 di petrolio e gas, che si riferiscono alle emissioni delle compagnie petrolifere nella loro produzione di petrolio e gas, piuttosto che alle emissioni causate dalla combustione di quest’ultimo.
Anche se un simile impegno da parte dell’industria sarebbe benvenuto, non coprirebbe le emissioni Scope 3 (ovvero il consumo finale di petrolio e gas), che rappresentano la maggior parte delle emissioni di petrolio e gas sul totale delle emissioni legate all’energia (il 40%, contro il 15 % di Scope 1 e Scope 2). Gli impegni settoriali sono fondamentali per aumentare le ambizioni, e iniziative come l’alleanza per il cemento a basse emissioni di carbonio o per l’acciaio e l’alluminio verdi potrebbero portare alla discussione il concetto di “club climatici settoriali”.
ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Un consenso su un obiettivo globale per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica sembra a portata di mano e potrebbe essere adottato alla COP28. Fortemente sostenuto dall’Unione europea, l’obiettivo mira a triplicare la capacità di energia rinnovabile portandola a 11 TWh e a raddoppiare i miglioramenti in termini di efficienza energetica entro il 2030. Il recente accordo tra Stati Uniti e Cina al vertice Biden-XI ha segnalato una rinnovata cooperazione tra i due maggiori inquinatori del mondo.
Anche i leader del G20 sono favorevoli all’adozione globale delle energie rinnovabili: la Dichiarazione di Nairobi, adottata a conclusione dell’Africa Climate Summit di settembre, comporta che i leader africani ora hanno l’obiettivo di raggiungere 300 GW di capacità di generazione di energia rinnovabile per l’Africa entro il 2030. Le discussioni alla COP28 dovrebbero consolidare tali impegni.
LA FINANZA CLIMATICA
L’articolo 2 dell’Accordo di Parigi stabilisce che sarà attuato sulla base di un principio di responsabilità comuni, ma differenziate e rispettive capacità tra i Paesi. Agli occhi dei Paesi in via di sviluppo, questo implica che, mentre tutti i partecipanti alla COP devono intraprendere azioni per affrontare la crisi climatica, gli emettitori storici hanno maggiori responsabilità e capacità di sostenere i Paesi in via di sviluppo per ridurre le loro emissioni.
Questa questione, al centro della governance globale del clima, si riduce concretamente all’impegno assunto nel 2009 dai Paesi ricchi di fornire 100 miliardi di dollari all’anno di sostegno finanziario per il clima ai Paesi in via di sviluppo. Questi ultimi lamentano da tempo che i finanziamenti per il clima spesso vengono erogati in quantità troppo piccole, troppo lentamente e ingiustamente.
Nel 2021, i Paesi sviluppati hanno mobilitato 89,6 miliardi di dollari a favore dei Paesi in via di sviluppo, il 68% dei quali è stato stanziato tramite prestiti agevolati. Sebbene ciò sia adeguato per ridurre il rischio, potrebbe peggiorare la passività del debito dei Paesi in via di sviluppo, che sostengono una quota maggiore di sovvenzioni.
L’IMPEGNO DEI PAESI RICCHI VERSO I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Ai Paesi ricchi non verrà chiesto solo di colmare finalmente il divario rispetto all’impegno di 100 miliardi di dollari all’anno a partire dal 2009, ma anche di avviare negoziati su un nuovo obiettivo annuale di finanza climatica per sostituire (e aumentare) l’impegno di 100 miliardi di dollari. I Paesi si sono impegnati ad adottare questo nuovo obiettivo quantificato collettivo (NCQD) entro la fine del 2024 ed entrerà in vigore nel 2025.
Le cifre principali difficilmente verranno decise a Dubai, ma verrà dato il tono per ulteriori discussioni nel corso del prossimo anno. Inoltre, la riforma delle banche multilaterali di sviluppo probabilmente sarà al centro delle discussioni sulle strategie di condivisione del rischio e su come mobilitare maggiori finanziamenti privati.
I FINANZIAMENTI PER IL CLIMA
La COP27 ha invitato i Paesi sviluppati ad aumentare i finanziamenti bilaterali per il clima e ad aumentare il sostegno ai meccanismi di finanziamento del clima, come il Fondo verde per il clima. Il primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, ha sostenuto l’iniziativa Bridgetown a Sharm El-Sheik come una proposta chiave a sostegno della riforma dei sistemi finanziari internazionali. Una riforma di questo tipo comporterebbe una ricapitalizzazione delle banche di sviluppo, consentendo loro di fornire molta più assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Sebbene non siano state finalizzate proposte concrete, il vertice di Parigi del giugno 2023 ha portato avanti le discussioni in questo ambito. La Banca Mondiale, il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Francia hanno concordato di sospendere temporaneamente il rimborso del debito dei Paesi colpiti da disastri climatici.
Un altro strumento che sta guadagnando slancio è lo scambio debito-clima, con cui i Paesi in via di sviluppo ricevono condizioni favorevoli su finanziamenti esterni finalizzati a specifici progetti di conservazione o legati al clima. Ad esempio, le Barbados di recente hanno raggiunto un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca interamericana di sviluppo per 300 milioni di dollari per finanziare l’ammodernamento delle proprie infrastrutture idriche.
IL FONDO “PERDITE E DANNI”
Un risultato della COP27 è stato il lancio del “fondo perdite e danni”, insieme ad un “comitato transitorio” per guidarne l’operatività. Il comitato ha raggiunto il consenso nel novembre 2023, aprendo la strada all’approvazione alla COP28. L’adozione del testo sembra probabile, ma sorgono una serie di domande impegnative: in primo luogo, l’accordo della COP27 ha imposto di stabilire un sostegno ai Paesi in via di sviluppo vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico. Tuttavia, non c’è consenso su quali Paesi possano beneficiare del sostegno. Il testo finale propone un sistema di allocazione delle risorse che fisserebbe una percentuale minima di assegnazione ai Paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari, ma manca di esempi specifici.
In secondo luogo, l’accordo invita i Paesi sviluppati a guidare i finanziamenti e lascia che gli altri contribuiscano volontariamente. Questo compromesso è nato dalle controversie con gli Stati Uniti sulla resistenza agli obblighi finanziari. Insieme all’Ue, gli USA hanno sostenuto una responsabilità condivisa con i paesi non inclusi nell’Allegato II, come l’Arabia Saudita e la Cina. Il testo enfatizza la cooperazione senza responsabilità o risarcimento e ignora le emissioni storiche, che sono un punto di contesa per i Paesi in via di sviluppo.
LE QUESTIONI IN SOPESO
In terzo luogo, la Banca Mondiale è l’ospite provvisorio del fondo perdite e danni. Tuttavia, non esiste un limite di durata e non è stata presa alcuna decisione sui futuri host. Questa concessione fatta dai Paesi in via di sviluppo alle richieste degli Stati Uniti e dell’Ue ha incontrato resistenza, perché la Banca Mondiale preferisce i prestiti piuttosto che le sovvenzioni, la lentezza nell’erogazione dei finanziamenti durante i disastri climatici e il dominio degli Stati Uniti. I Paesi in via di sviluppo hanno favorito una struttura indipendente basata sull’UNFCCC, come il Fondo verde per il clima.
In quarto luogo, il testo finale manca di chiarezza sull’entità del fondo e le fonti di finanziamento menzionano “un’ampia varietà di fonti”, come sovvenzioni e prestiti agevolati. Questi sono destinati ad essere abbinati a mezzi innovativi provenienti da fonti di finanziamento pubbliche, private e filantropiche. I Paesi in via di sviluppo danno invece priorità ai finanziamenti basati sulle sovvenzioni. Le recenti dichiarazioni dell’Ue riguardo alla fornitura di contributi significativi al fondo hanno sottolineato le differenze tra l’Ue e gli USA riguardo a questo problema, e il presidente Biden è stato molto meno esplicito riguardo all’importo e ai tempi dei contributi. Le tensioni sono elevate, poiché il mancato accordo sul fondo sarebbe il segno più visibile del fallimento della COP28.
L’ADATTAMENTO CLIMATICO
Oltre alla maggiore esposizione e sensibilità ai cambiamenti climatici, la limitata capacità di adattamento rende i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Il deficit di adattamento è sempre più al centro dell’attenzione dei Paesi in via di sviluppo nei negoziati sul clima. Il finanziamento dell’adattamento è difficile, poiché i progetti non creano necessariamente un business case, e quindi non attirano capitali privati nella stessa misura dei progetti di mitigazione. I progetti di mitigazione sono infatti di gran lunga i maggiori destinatari dei finanziamenti per il clima.
Alla COP27, nonostante la resistenza iniziale, la conferenza ha confermato l’impegno di Glasgow a raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento, promuovendo ulteriori contributi allo sviluppo dei fondi nazionali. Il lancio dell’Agenda di adattamento di Sharm-El-Sheikh ha stabilito un modello per misure globali di adattamento in tutti i settori chiave.
Un altro possibile successo per la COP28 sarebbe l’adozione dell’Obiettivo Globale sull’Adattamento, che offrirebbe un quadro internazionale sull’adattamento, fissando obiettivi e indicatori per monitorare e quantificare i progressi. Le discussioni sull’adattamento hanno incontrato ostacoli sulla questione del finanziamento e della misurazione. Una cosa è misurare le emissioni, un’altra è valutare il capitale naturale di un certo ecosistema o il livello di resilienza agli shock climatici di una comunità.
Il livello di flessibilità del nuovo quadro di adattamento è stato a lungo dibattuto: i Paesi in via di sviluppo vorrebbero vedere la creazione di obiettivi assoluti più specifici (ad esempio, l’India chiede un obiettivo sulla riduzione a zero della mortalità dovuta a eventi estremi e disastri legati al clima), in modo che riflettano i diversi livelli di esposizione di un dato Paese al cambiamento climatico e della sua disponibilità di finanziamenti a livello nazionale.
AGRICOLTURA E SISTEMI ALIMENTARI
La scorsa estate il ministro per i Cambiamenti climatici e l’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che la presidenza della COP sarà “iperfocalizzata” sui sistemi alimentari. A partire dalla COP27 l’attenzione sull’argomento è aumentata, in parte grazie alla pubblicazione di uno studio di Nature secondo cui i sistemi alimentari rappresentano il 34% delle emissioni globali di gas serra.
L’Agenda sui sistemi alimentari e l’agricoltura è stata lanciata nel luglio 2023, con l’obiettivo principale di allineare i sistemi alimentari nazionali e le politiche agricole con gli NDC e i piani nazionali di adattamento (National Adaptation Plans – NAP) entro il 2025. Si tratterebbe di un risultato importante, poiché l’agricoltura tende a passare in secondo piano rispetto agli accordi di mitigazione, e le principali economie storicamente hanno fatto poco per ridurre le emissioni nel settore. La presidenza della COP28 probabilmente sottolineerà il ruolo della tecnologia, con gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti che probabilmente collaboreranno verso obiettivi comuni.
COP 28: GLI INDICATORI DI SUCCESSO
Per Bruegel è probabile che la COP28 si concluderà con un risultato contrastante, che sarà celebrato da alcuni e denigrato da altri. Gli indicatori di successo dipenderanno in gran parte da impegni più ambiziosi e da azioni concrete per promuovere l’attuazione degli obiettivi climatici, come:
– Bilancio globale: i Paesi si mostrano pronti ad aumentare l’ambizione dei loro piani di decarbonizzazione entro il 2030 seguendo il GST
– Eliminazione graduale dei combustibili fossili e obiettivi globali in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica: le parti raggiungono un accordo sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili entro una data specifica e chiariscono che il loro utilizzo dovrà essere ridotto solo a determinati combustibili fossili difficili da abbattere. I Paesi sviluppati sostengono nuovi obiettivi globali sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica con impegni finanziari reali, come l’Ue si è impegnata a fare nel novembre 2023
– Finanziamenti per il clima: i Paesi ricchi intensificano i loro sforzi e raggiungono il livello di 100 miliardi di dollari in finanziamenti per il clima, come concordato nel 2009, aumentando al tempo stesso la loro attenzione all’adattamento. La COP28 apre la strada all’approvazione di un ambizioso nuovo obiettivo quantificato collettivo entro la fine del 2024
– Fondo perdite e danni: le parti approvano e rendono operative le proposte del comitato di transizione, risolvendo le importanti questioni in sospeso
– Adattamento: le parti concordano un obiettivo globale ambizioso in materia di adattamento e abbracciano un quadro tecnico chiaro basato su obiettivi guidati dalla scienza
– Cibo: i governi iniziano ad allineare le loro politiche agricole con i loro NDC, in vista di iniziare a decarbonizzare un settore a lungo trascurato
In conclusione, la COP28 rappresenta un’importante opportunità per il Nord del mondo di riconquistare parte della credibilità nel Sud del mondo che nel corso degli altri è stata persa, anche a causa della pandemia e della crisi energetica. Saranno fondamentali delle azioni serie per garantire adeguati finanziamenti per il clima, per il fondo perdite e danni e per l’adattamento climatico.