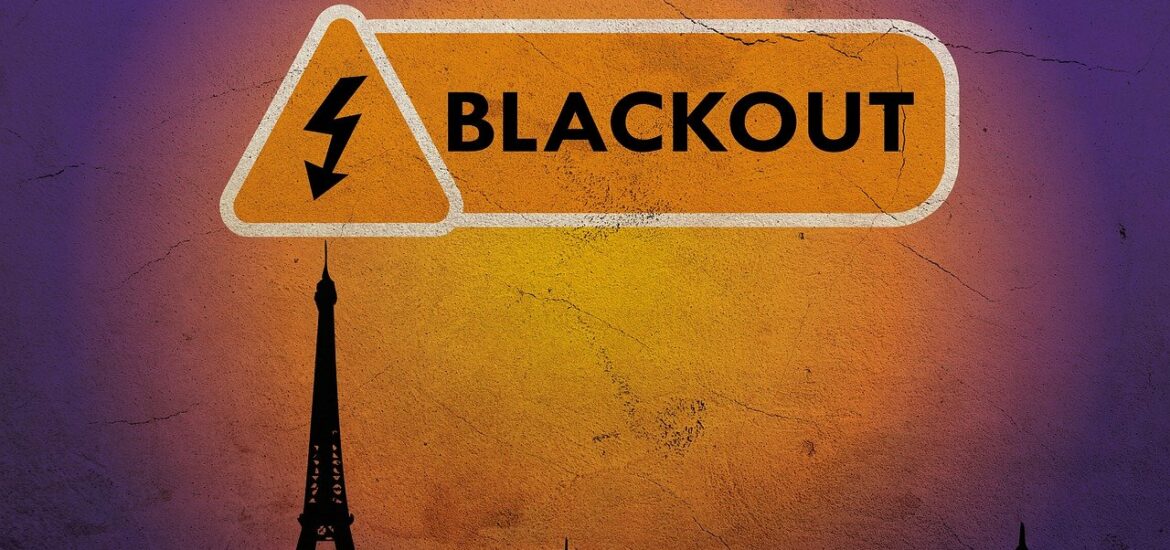La transizione è un percorso lungo e tortuoso, ma la neutralità tecnologica può rappresentare il faro che ci guida verso il porto della decarbonizzazione. Negli ultimi dieci anni abbiamo trascurato completamente una delle componenti della sostenibilità: la sicurezza energetica È quanto emerge dal convegno organizzato oggi dall’Associazione Italiana Economisti dell’Energia (AIEE), intitolato “Il settore energetico nel 2022 e le prospettive per il 2023 alla luce del pacchetto REPowerEU”. L’evento ha messo in evidenza il punto di vista di diverse associazioni di categoria riguardo le sfide del RePowerEU
La transizione è un percorso lungo e tortuoso, ma la neutralità tecnologica può rappresentare il faro che ci guida verso il porto della decarbonizzazione. Negli ultimi dieci anni abbiamo trascurato completamente una delle componenti della sostenibilità: la sicurezza energetica È quanto emerge dal convegno organizzato oggi dall’Associazione Italiana Economisti dell’Energia (AIEE), intitolato “Il settore energetico nel 2022 e le prospettive per il 2023 alla luce del pacchetto RePowerEU”. L’evento ha messo in evidenza il punto di vista di diverse associazioni di categoria e stakeholder riguardo le sfide del RePoweEu.
LA TRANSIZIONE ENERGETICA NON È UNA PASSEGGIATA
“Repower EU prevede di passare dal 40% al 45% di copertura delle rinnovabili sui consumi finali di energia. Questo significa sostanzialmente avere tra l’80 e l’85% della domanda elettrica coperta da rinnovabili nel 2030. Ricordo che il paccchetto RepowerEU sottolinea che il processo di elettrificazione e di efficienza energetica e diffusione delle rinnovabili dovrebbero portare a una consistente riduzione della domanda di gas nei prossimi anni. È un salto in avanti rispetto al già sfidante FitFor55 ed è attualmente oggetto di discussione e implementazione a livello europeo. Quindi, è ancora in fase di attuazione e ci sono posizioni insolite dal punto di vista dell’articolazione dei partiti europei. Abbiamo visto manifestarsi maggioranze e minoranze, anche a livello di Consigli Europei, che non sono quelle tradizionali”, ha detto Giovanni Battista Zorzoli, presidente dell’Associazione Italiana Economisti dell’Energia (AIEE).
“Si può discutere se è attuabile o meno il RePowerEU, resta il fatto che come tutti i Paesi europei dobbiamo riscrivere il nostro Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Realizzare gli obiettivi del RePower EU al 2030 vuol dire dimezzare la domanda di gas naturale. La transizione energetica è una cosa maledettamente complicata, che pone problemi che richiedono una risposta chiara. Un tema importante, spesso sottovalutato, è se ci sia o meno compatibilità in termini di asset strategici tra RepowerEU e il piano di rendere l’Italia hub del Mediterraneo. Se è compatibile, è importante sapere come. Se invece non lo è, vorrei capire perché il Governo sta seguendo questa strada”, ha aggiunto G. B. Zorzoli.
I BENEFICI DI DIVENTARE HUB MEDITERRANEO DEL GAS
“Il Governo sta lavorando al progetto di Hub del gas. L’Italia ha saputo reagire molto meglio rispetto agli altri Paesi perché godiamo di un sistema infrastrutturale molto differenziato, ha aziende che producono gas anche fuori dall’Italia quindi abbiamo sostituito meglio le forniture russe. Si apre per noi un’occasione. Fino adesso i flussi erano Est-Ovest, circa 150 miliardi di metri cubi l’anno con altre fonti. L’Italia si trova in una zona di transito tra il Sud, l’Africa che avrà un grande ruolo nella produzione del gas, può sfruttare la sua posizione e valorizzare il ruolo e la capacità imprenditoriale che possediamo. Il progetto di hub non è incoerente con le politiche del RepowerEU perché è vero che si consumerà più gas ma aiuterà la gradualità della transizione”, ha affermato Marta Bucci, direttore generale di Proxigas.
L’IMPORTANZA DELLA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA
“L’elettrico sarà fondamentale ma non sarà la sola tecnologia. La neutralità è prendersi la responsabilità di diversificare il sistema energetico, garantire la resilienza. Un processo basato su una sola tecnologia è fragile, lo abbiamo imparato in questi anni. Non si può fondare la politica energetica solo sulla produzione di un’unica tecnologia. Ci auguriamo che l’esperienza ci lasci la consapevolezza di valorizzare i diversi vettori e tecnologie eliminando le logiche dei divieti, come alla commercializzazione dei motori a combustione interna e alle caldaie a gas. Per cogliere tutti i contributi che le fonti possono dare dobbiamo tornare a ragionare in termini di neutralità tecnologica”, ha affermato Marta Bucci.
“Non mi scandalizza che di fronte a una guerra sotto casa si verifichi uno shock energetico, è normale che a febbraio/marzo ci sia stata una fiammata dei prezzi del gas e del petrolio a causa dell’invasione russa in Ucraina. Nessun sistema energetico può avere gli strumenti per reagire senza traumi a un evento così straordinario. Mi sconvolge che nel quarto trimestre 2021 il gas in Europa costava il 400% in volte in più semplicemente perché si era ripristinata la domanda pre – Covid. Questo vuol dire infatti che non abbiamo un sistema di sicurezza energetica un minimo reattivo. Nello stesso periodo negli Usa il gas è aumentato del 20%. Negli ultimi dieci anni la Ue ha trascurato completamente una delle componenti della sostenibilità: la sicurezza energetica.
“È necessario avere una visione coerente che porti al minimo rischio possibile. Questo è possibile con una programmazione ambiziosa ma realizzabile. Siamo tutti favorevoli all’aumento della produzione di rinnovabili, ma serve un sistema che sia in grado di realizzarlo. Non possiamo continuare ad accumulare ritardo ogni anno. Esistono diversi vincoli allo sviluppo, il punto è programmare, diversificare dal punto di vista geografico e delle fonti. Il nostro progetto è introdurre gradualità con materie prime rinnovabili che riducono l’utilizzo del petrolio e gradualmente lo sostituiranno”, ha affermato Claudio Spinaci, Presidente di Unione Energie per la Mobilità (UNEM).
SPINACI: SCEGLIERE UNA SOLA TECNOLOGIA METTE A RISCHIO LA TRANSIZIONE
“Esistono enormi quesiti irrisolti in tutte le tecnologie. Il livello di ricerca per traguardare gli obiettivi del 2030 e del 2050 ancora non lo possiede nessuna filiera. La questione dell’evoluzione dei carburanti low carbon fa il paio con il problema della disponibilità di materie prime per la produzione di batterie. Stiamo sviluppando la nostra strada: biogas oggi e carburanti sintetici domani, passando attraverso il waste to fuel. Nel campo dei carburanti abbiamo enormi potenzialità di utilizzo dei rifiuti. Serve un percorso che si affianchi a quello che oggi viene indicato come unico percorso dalle normative Ue. Un approccio che secondo me mette a rischio la transizione. Se certe sfide tecnologiche non venissero vinte, torneremmo indietro invece di andare avanti. Se qualcuno venti anni fa ci avesse detto che avremmo aumentato nuovamente la produzione di energia da carbone nessuno ci avrebbe creduto.
È evidente che dobbiamo avere una programmazione cauta che affianchi nuove tecnologie a quelle tradizionali, con piani realizzabili. Il nostro approccio è inclusivo e non esclusivo, l’opposto di quello che ha adottato la Commissione. Una visione che probabilmente è la causa di quello che è successo nel 2021. Dobbiamo guardare a cosa non ha funzionato nelle politiche energetiche dell’Unione Europea”, ha aggiunto Claudio Spinaci.
LA TRANSIZIONE DELL’AUTOMOTIVE
“I biocarburanti hanno dei limiti, il problema principale è l’industrializzazione. Tuttavia, permetterebbero di risolverebbe il problema su tutta la filiera della mobilità perché decarbonizzano immediatamente ogni veicolo. Non c’è bisogno di un cambiamento massiccio del parco auto, che comunque andrebbe fatto per una questione di inquinamento locale, piuttosto che di riduzione della CO2. Un obiettivo, quest’ultimo, che può essere realizzato attraverso carburanti a basso contenuto di carbonio. Il problema è che mancano i fattori abilitanti, primo fra tutti un metodo ufficiale per il calcolo del lyfe cycle assessment. Se consideriamo solo la quantità di CO2 emessa, i biocarburanti non mostrano i loro benefici. Dovremmo affiancare alla tecnologia prevalente tutte le altre in modo da ridurre il rischio di problemi e trovare la soluzione ottimale”, ha concluso Spinaci.
“Serve un approccio Pniec bilanciato e assicurato. Una tecnologia deve essere una sorta di riserva per l’altra. Dobbiamo trovare il modo di produrre l’energia per sostituire la tecnologia principale. Il Pniec dovrebbe indicare strade alternative per raggiungere gli obiettivi definiti, percorribili nel caso in cui non sia possibile seguire la via principale. Fino adesso abbiamo avuto un approccio statico che definiva tutto senza considerare deviazioni”, afferma Guido Bortoni, Chairman Cesi.
“Lo scontro sulle automobili è un match tra diversi interessi. Lo stesso succede nel settore del gas. Da una parte troviamo la lobby dei petrolieri che vorrebbe costruire liquefattori e investire per far diventare gli Usa l’unico fornitore di gas dell’Europa. L’altra lobby è quella composta dalle persone che vogliono erigere una sorta di frontiera di protezionismo. Gli esempi di questi scontri di lobby sono all’ordine del giorno e possono modificare le politiche pubbliche”, conclude Guido Bortoni.